[432] 1921: ITALIA NEL CAOS
scioperi, occupazioni e disagio sociale

Quando il fragore delle armi cessò nel 1918, l’Italia non trovò la pace, ma un’agonia silenziosa. Il paese era stremato, con città sventrate dai bombardamenti, campagne impoverite e un’economia in ginocchio. Ovunque si respirava l’odore acre della miseria e della disperazione. La popolazione si aggrappava alla speranza di un futuro migliore, ma la realtà restituiva solo disillusione. Le istituzioni, deboli e frammentate, faticavano a rispondere alle necessità urgenti del paese, lasciando spazio a nuovi movimenti politici che cercavano di capitalizzare il malcontento.
I reduci rientrarono nelle loro case, convinti di essere accolti come eroi. Ma la nazione per cui avevano rischiato la vita sembrava averli dimenticati. Le promesse fatte durante il conflitto si rivelarono vuote: non c’erano terre da distribuire, né impieghi garantiti. Molti, incapaci di reinserirsi nella società, si abbandonarono alla rabbia e alla frustrazione. Questo sentimento di abbandono e tradimento alimentò la nascita delle prime squadre d’azione fasciste, composte proprio da quegli uomini che, dopo aver imparato la violenza in trincea, non riuscivano più a farne a meno.
Il disagio era particolarmente forte tra i giovani che non riuscivano a immaginare un futuro stabile. L’inflazione galoppante erodeva i risparmi, e i prezzi dei beni di prima necessità aumentavano vertiginosamente. Per molti ex soldati, la disillusione si trasformò in violenza politica, alimentando tensioni che avrebbero segnato il decennio successivo.
Il malcontento serpeggiava in ogni angolo del paese. Operai e contadini, stanchi di lavorare per una miseria, iniziarono scioperi e occupazioni di fabbriche e terreni. Le proteste si moltiplicarono: da Milano a Torino, da Bologna alla Sicilia, le folle si riversavano per le strade, chiedendo giustizia sociale e migliori condizioni di vita. Gli industriali e i proprietari terrieri, spaventati dalla forza delle proteste, chiesero protezione allo Stato, ma il governo era troppo fragile per intervenire con fermezza.
I sindacati acquisirono sempre più potere, mentre gli scioperi coinvolgevano intere città. Gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine divennero all’ordine del giorno, trasformando le strade in veri e propri campi di battaglia. Nel biennio rosso (1919-1920), le occupazioni di fabbriche raggiunsero l’apice, e molti temevano che l’Italia stesse per precipitare in una rivoluzione simile a quella russa del 1917.
Anche Montebello, una piccola comunità apparentemente lontana dai grandi sconvolgimenti politici, fu travolta dal caos del dopoguerra. Qui la tensione si manifestò nelle campagne, tra incendi di fienili, scioperi e furti sempre più frequenti. L’apice della violenza fu raggiunto nel 1921, quando un treno diretto Venezia-Milano fu fatto deragliare nella zona della cotrada Fracanzana. L’incidente provocò la morte del macchinista e ferì, in modo grave, cinque passeggeri. La notizia si diffuse rapidamente, aumentando il senso di insicurezza e paura.
Nel frattempo, la criminalità divenne un problema quotidiano. Tra maggio e agosto dello stesso anno, Montebello assistette a una serie di episodi di sangue: un giovane fu ucciso durante un furto, un carabiniere perse la vita in uno scontro a fuoco con una banda di rapinatori. La popolazione, disorientata, si chiedeva se il paese sarebbe mai tornato a conoscere la pace.
In un clima di crescente instabilità, anche la religione divenne bersaglio di violenze e atti di dissacrazione. A Montebello, una croce venne data alle fiamme, un negozio di un esponente cattolico devastato e una processione religiosa interrotta da manifestanti anticlericali. La lotta non era più solo politica ed economica, ma si estendeva al tessuto più profondo della società, mettendo in discussione valori e tradizioni secolari.
Nel frattempo, il fascismo cresceva. Le squadre d’azione iniziarono a reprimere con la violenza le proteste operaie e contadine. Gli scontri tra socialisti e fascisti si fecero sempre più frequenti e cruenti, contribuendo a un clima di paura e incertezza che avrebbe presto portato alla Marcia su Roma.
Tra il 1919 e il 1922 Montebello visse una delle fasi più critiche della sua storia moderna. Il paese era un campo di battaglia tra ideologie opposte: socialisti e comunisti da un lato, nazionalisti e fascisti dall’altro. L’Italia era diventata una polveriera pronta ad esplodere, la paura di una rivoluzione bolscevica, come quella avvenuta in Russia, spinse la borghesia e i ceti medi a cercare un’alternativa che garantisse ordine e sicurezza. Fu in questo contesto che Benito Mussolini, con il suo movimento fascista, iniziò a guadagnare consenso, presentandosi come il solo in grado di riportare stabilità.
Nel 1922, la Marcia su Roma segnò la fine di questo periodo turbolento e l’inizio di una nuova era: quella del regime fascista. Mussolini e i suoi sostenitori riuscirono a prendere il potere sfruttando il malcontento diffuso, la paura della rivoluzione e l’incapacità del governo liberale di affrontare la crisi. Da quel momento, l’Italia avrebbe conosciuto vent’anni di dittatura, guerra e repressione.
Il primo dopoguerra non fu dunque un periodo di ricostruzione, ma una lenta e dolorosa discesa verso una nuova era di conflitti. L’Italia non aveva trovato la pace: si stava solo preparando alla prossima tempesta.
FOTO: Deragliamento del diretto Venezia-Milano nella notte del 5 giugno 1921, nei pressi della contrada Fracanzana (Collezione privata Umberto Ravagnani).
NOTA: Vedi anche l’articolo n. [209] del 26 novembre 2020 “Un deragliamento sospetto“.
BIBLIOGRAFIA: – G. Sabbatucci, “La crisi italiana del primo dopoguerra”, 1976.
– Diario manoscritto di Mons. Antonio Zanellato prevosto di Montebello dal 1919 al 1952 (Archivio parrocchiale di Montebello).
Umberto Ravagnani
Se hai FACEBOOK e l’articolo ti ha soddisfatto metti MI PIACE 
Oppure lascia un commento qui sotto…



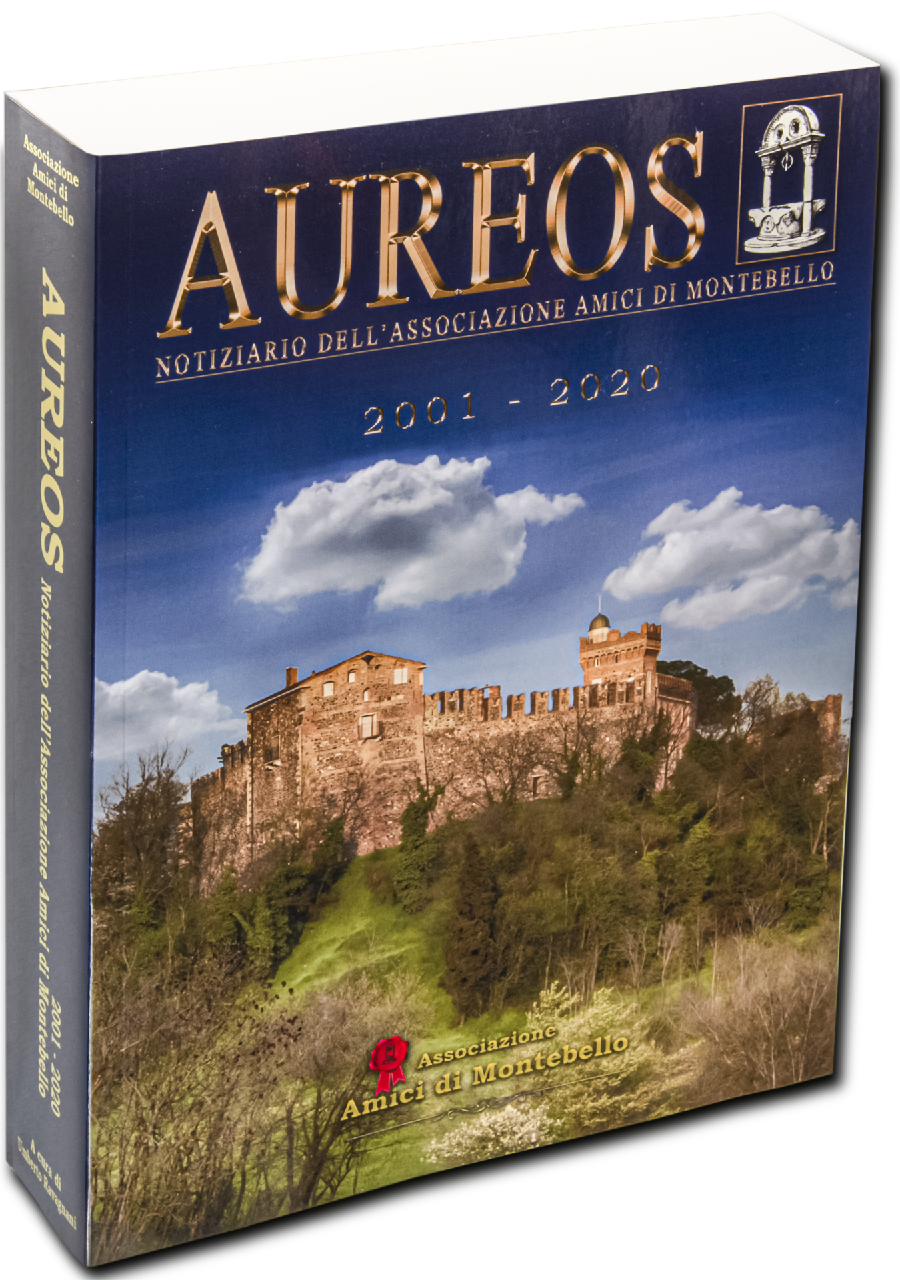
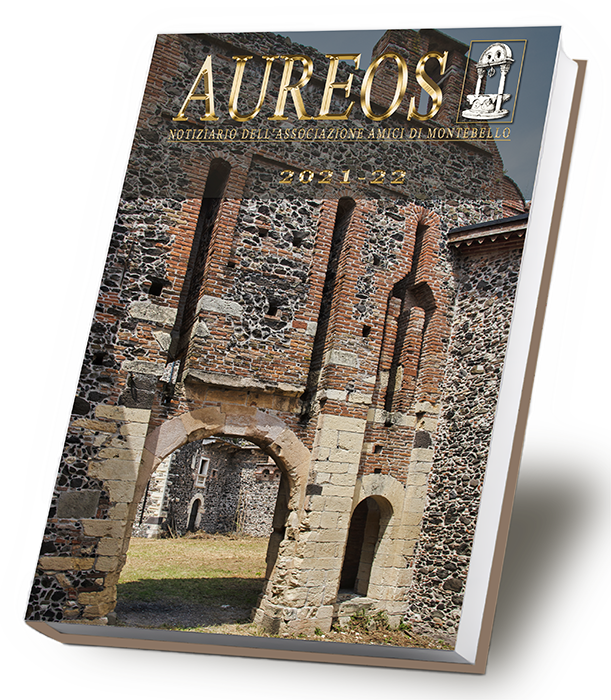



 « Sono Elisa Longarato e ringrazio Elena Bellina (New York University) e Giorgia Alù (Sidney University) per l’invito. È un onore per me partecipare a questo incontro. Mi scuso in anticipo per il mio pessimo inglese.
« Sono Elisa Longarato e ringrazio Elena Bellina (New York University) e Giorgia Alù (Sidney University) per l’invito. È un onore per me partecipare a questo incontro. Mi scuso in anticipo per il mio pessimo inglese.